L’Amore più grande
L’Amore più grande
“L’Amore più grande” è la nuova Lettera pastorale di monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria, indirizzata “al clero, ai consacrati, ai fedeli laici e a tutti i fratelli di buona volontà“.
Clicca sui bottoni qui sotto per scaricare la Lettera pastorale in PDF.
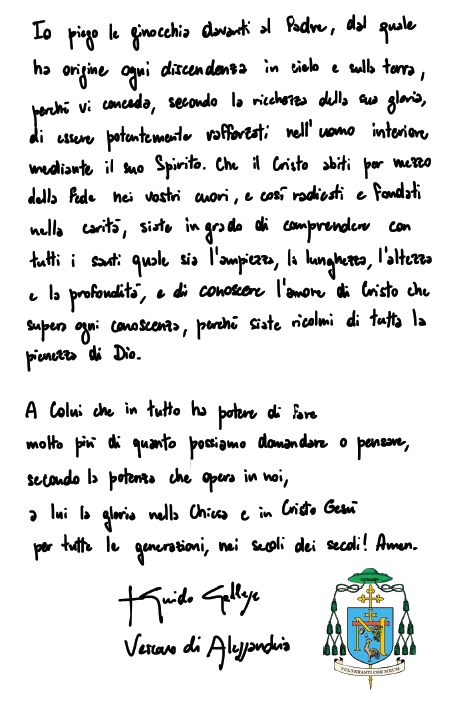
L’Amore più grande
Lettera pastorale 2025-2026
Guido Gallese,
vescovo, servitore
della salvezza per la Chiesa
di Alessandria, a tutti gli amati fratelli e sorelle nella fede:
presbiteri, diaconi, religiosi, religiose e fedeli laici.
Pace a voi!
Il Signore vi ricolmi
di ogni grazia e benedizione
in questo anno giubilare
perché possiate sperimentare
la gioia che dà sapore
alla nostra vita cristiana.
La lettera pastorale
Quest’anno vorrei cominciare la nostra riflessione dal significato e dall’utilizzazione della lettera pastorale nella vita della Diocesi, delle unità pastorali, delle parrocchie e delle comunità elettive. La lettera pastorale è uno strumento mediante il quale il Vescovo della Diocesi scrive ai suoi fedeli, analogamente a quanto, nella prima comunità cristiana, facevano gli apostoli e i vescovi. Per ricordare questo ho scelto, nelle lettere pastorali degli ultimi anni, di mettere un indirizzo di saluto che descrive il mittente all’inizio della lettera e un saluto conclusivo alla fine in uno stile simile a quello che veniva usato nel Nuovo Testamento. Anzi, in esse il saluto finale era di solito copiato di sana pianta da una lettera del Nuovo Testamento.
A cosa serve una lettera pastorale
La lettera pastorale si inserisce nella relazione tra il pastore e il suo popolo. Nella Bibbia si parla diverse volte del pastore e del popolo.La maggior parte delle volte se ne parla intendendo che Dio è il pastore del suo popolo. Alcune volte il pastore è una persona incaricata da Dio per svolgere quel compito. È significativo che Gesù abbia dato direttamente e specificamente a Simone di Giovanni, che ha chiamato Pietro, il compito di pascere il suo gregge. Da qui la lunga tradizione della Chiesa che al suo interno destina delle persone a svolgere il ministero di pastori.
Due difetti comuni
Che cosa aspettarsi da una lettera pastorale? Chiaramente, nel bisogno di concretezza che connota noi esseri umani, ci aspetteremmo delle indicazioni semplici e precise sulle cose da fare e su come comportarci nella vita cristiana. Tuttavia le nostre attese sono spesso viziate da due difetti. Il primo è la sordità selettiva, il secondo è il sentirci buoni per quello che facciamo.
La sordità selettiva consiste nel fatto che alcune cose non le vogliamo sentire. Gesù non la combatteva, l’assecondava. Io credo che, in una certa misura, questa sordità sia un atteggiamento psicologico di difesa per evitare di perdere tempo e motivazione in cose che istintivamente valutiamo di non riuscire a fare. Lo stile di Dio non è quello di forzarci. Santa Bernadette, nelle sue numerose interazioni con persone che non credevano a quello che lei raccontava, era molto arrendevole: “Non sono incaricata di farvelo credere, sono incaricata di dirvelo”. Gesù, addirittura, molte volte certe cose nemmeno le diceva ad alcune categorie di persone: in molte occasioni parla alla gente in parabole, diversamente da quando parla ai Dodici. La spiegazione che Gesù dà di questo suo comportamento è sconcertante: “Per questo a loro parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: «Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!»” (Matteo 13,13-15). Sorge quindi un dubbio: “… dunque lo scopo di Gesù non è quello di far sì che la gente guardi, ascolti e si converta!”. Non è esattamente così: lo scopo di Gesù non è quello di convincere a tutti i costi, ma quello di attrarre l’uomo perché possa compiere delle scelte libere e responsabili. Gesù desidera che noi siamo in grado di compiere un processo sano di scelta che ci porti poi alle conseguenti azioni con la forza dello Spirito Santo.
Il secondo vizio ricorrente è il sentirci buoni in virtù di quello che facciamo. Detto in parole paoline: il pensare di essere giustificati (resi giusti, resi santi) non in virtù della fede, ma in virtù delle opere della legge. Preferiamo di gran lunga obbedire ad alcuni comandi di Dio piuttosto che doverci angustiare a pensare e a scegliere responsabilmente con la nostra libertà e autonomia. Qualcuno potrebbe obiettare: “Non è vero: l’uomo ha addirittura perso la propria comunione con Dio a causa del suo desiderio di autonomia”. Non è esattamente così: a noi piace ribadire il nostro senso di autonomia quando abbiamo il desiderio di fare ciò che ci pare. Quando invece si tratta di dover scegliere liberamente e responsabilmente qualcosa di cui dobbiamo vivere poi le conseguenze, siamo molto meno baldanzosi e preferiamo delegare almeno la responsabilità della scelta.
La funzione della lettera pastorale
Dette queste cose, la lettera pastorale serve al pastore per esortare il gregge a lui affidato a seguire Cristo-Via. Questo infatti è il primo compito del vescovo: indicare che Cristo è la risposta al bisogno dell’uomo, è la Verità, è la Vita; e garantire la sequela di Cristo: è la Via. Gesù ha detto: “Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Matteo 16,24). E qui si capisce bene come una lettera pastorale diventi immensamente complicata sia per chi la scrive, sia per chi la legge. Si tratta di esortare le persone a prendere la croce e questa non è una cosa facile da spiegare; prima di tutto perché non è nemmeno una “spiegazione”: non posso “togliere le pieghe” della croce; la croce rimane croce. L’approccio alla croce non può essere solo frutto di un ragionamento: la cosa difficile è viverla. Il lettore può trovare un aiuto in quello che legge, a patto che riesca ad entrare nella forma mentis di Gesù per vivere quella novità di vita che scorge grazie all’esortazione del suo pastore. Passiamo allora ad individuare più precisamente i due elementi coinvolti in questa relazione stabilita dalla lettera pastorale: il pastore e il gregge, ovvero il popolo di Dio, ovvero il corpo mistico di Cristo di cui Egli è capo.
I pastori
Carissimi confratelli nell’ordine del presbiterato e del diaconato, di voi si parla sin dagli inizi della Chiesa: San Paolo costituisce nelle comunità degli “anziani” (in greco: presbiteri, cfr Atti 14,23), Sant’Ignazio di Antiochia, morto a Roma nel 107 d.C., divorato dalle belve nel circo, descrive nelle sue lettere delle chiese locali organizzate: esorta i ministri sacri, presbiteri e diaconi, a vivere in accordo tra loro e in comunione con il vescovo, come le corde alla cetra. Carissimi, vi incoraggio con tutto il cuore ad aver cura della vostra vita spirituale, che è fondamento di ogni vostra azione nel mondo. L’importante non è quello che fate, ma l’intensità, l’amore divino, la comunione, la forza dello Spirito con cui lo fate. Certo, vivere oggi un’intensità interiore nella vita spirituale è decisamente controcorrente e chiede un aiuto reciproco proprio per il fatto della solitudine che sperimentiamo. Aiutiamoci tra noi! Fatevi aiutare anche dai laici, vivendo una sana comunione spirituale, una condivisione del cammino nella quale non dobbiamo necessariamente mettere in pubblico tutti i tratti – anche morali – della nostra vita (come del resto, vale anche per i laici), ma siamo chiamati a condividere la fatica e la tensione del cammino verso Dio, compresi i fallimenti e le scoperte. Altrimenti rimaniamo insipidi, abbiamo valore solo per quelli che vedono la Chiesa come una sorta di “grande distribuzione” di servizi spirituali, e diventiamo incomprensibili per coloro che invece stanno sinceramente cercando Dio, che sono quelli per i quali siamo inviati.
Questo essere in mezzo al mondo, ma non del mondo (cfr Giovanni 17,13-19), questo abitare tra le case degli uomini (parà oikìa, tra le case, da cui: parrocchia), sembra molte volte antitetico ad una vera vita spirituale. Non dobbiamo scoraggiarci: in fondo questo è il ministero che ha scelto anche il Signore Gesù che, fa bene ricordarlo, è entrato nel mondo dalla porta di servizio nascendo in una grotta, ha vissuto a Nazareth, paese alla periferia di Israele, nazione alla periferia dell’Impero, si è mantenuto lavorando come falegname nel proprio modesto paese, ha svolto un ministero itinerante impegnativo, al punto che talvolta non avevano nemmeno tempo per mangiare (cfr Marco 6,31). Questa situazione, che viviamo sulla pelle quotidianamente, è ben descritta da Papa San Gregorio Magno, che dice: “Siccome per necessità di Ufficio debbo trattare con uomini del mondo, […] succede che molte volte sto ad ascoltare pazientemente le loro parole inutili. E poiché anch’io sono debole, trascinato un poco in discorsi vani, finisco per parlare volentieri di ciò che avevo cominciato ad ascoltare contro voglia, e di starmene piacevolmente a giacere dove mi rincresceva di cadere. Che razza di sentinella sono dunque io, che invece di stare sulla montagna a lavorare, giaccio ancora nella valle della debolezza? Però il creatore e redentore del genere umano ha la capacità di donare a me indegno l’elevatezza della vita e l’efficienza della lingua, perché, per suo amore, non risparmio me stesso nel parlare di lui” (San Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, Lib. 1, 11, 6). Carissimi, il Signore stesso ci accompagna in questo cammino: abbiate fiducia in Lui, non ritenetevi incapaci per questa missione: il Signore può suscitare in noi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore (cfr Filippesi 2,13).
Il gregge di Dio
Il popolo di Dio, spesso raffigurato con l’immagine del gregge, è al centro della narrazione di tutta la Bibbia, dall’Antico Testamento al Nuovo Testamento. È commovente vedere come Dio si prenda cura del suo popolo! I ministri ordinati sono coloro che hanno ottenuto il dono di grazia di un sacramento apposito per pascere il gregge a loro affidato. Non è però un dono per sé, è un dono per gli altri che chiede di affrontare tante rinunce per il Vangelo: una piccola minoranza del popolo di Dio è a servizio della stragrande maggioranza di esso (cfr Evangelii Gaudium 102). I pastori hanno il compito di pascere, di nutrire, il gregge di Dio, ma qual è l’obiettivo?
Lo scopo: diventare un solo corpo
Lo scopo del gregge di Dio è diventare un solo corpo, il corpo mistico di Cristo, di cui Gesù è il capo. È un’immagine che San Paolo usa per descrivere l’articolazione della comunità: essa è una cosa sola, ma non nel senso della massificazione, di prendere dentro tutti indiscriminatamente come se tutti fossero uguali, ma nel senso che ciascuno dentro la comunità ha una funzione ben precisa a favore del bene di tutti.
La Chiesa è il corpo di Cristo
Questa incorporazione viene instaurata dal sacramento del Battesimo e viene portata avanti attraverso la vita spirituale con gli altri sacramenti, la preghiera, la vita di comunità. Infatti il corpo di Cristo è la Chiesa, ci dice San Paolo: “Tutto infatti egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose” (Efesini 1,22-23). Questo bel testo ci dice che la Chiesa è la pienezza di Cristo, indicato come colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Dunque, noi siamo chiamati a diventare addirittura pienezza di Cristo in quanto suo corpo: egli infatti è il nostro capo. Questa pienezza però la si ottiene nel modo indicato dall’Apostolo delle genti: “Ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa” (Col 1,24). Questo diventare pienezza di Cristo passa dunque attraverso una sofferenza che si accompagna, in modo inaspettato, con una letizia. San Paolo ci dice ancora che noi veniamo articolati in un solo corpo mediante lo Spirito Santo: “Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra” (1Corinzi 12,12-14). Dal contesto del brano comprendiamo bene che è Dio che opera attraverso questo Corpo per mezzo dello Spirito Santo.
Incarnazione e salvezza
Il mistero dell’Incarnazione, mediante il quale il Verbo di Dio si è fatto uomo, si viene a completare nelle nostre vite nel momento in cui diventiamo corpo di Cristo, ovvero Cristo. Dio si è fatto uomo per portare all’uomo il potere di Cristo, non per ridurre l’uomo sotto il giogo di un insopportabile peso morale. Dio si fa uomo, l’uomo viene fatto Cristo, cristificato. A questo punto che scopo avrà lo Spirito Santo, che struttura il corpo di Cristo che è la Chiesa? È lo stesso del Cristo: portare salvezza.
L’atto sacerdotale è salvifico
E come lo Spirito Santo porta salvezza? L’unico elemento in grado di portare salvezza nella storia dell’umanità e quello che riconduce a Dio, la prima origine. Dio è amore. Ciò che porta salvezza all’uomo non può che essere un atto d’amore. Esso assume la configurazione di un sacrificio ovvero di un atto sacerdotale che ha la possibilità di rendere sacro ciò che di natura sua è profano. Ma questo atto sacerdotale è talmente potente che riesce a ribaltare persino una condanna a morte per tortura – nulla di più repellente –, facendone strumento della salvezza universale: la pietra scartata dai costruttori, pietra d’inciampo, è diventata testata d’angolo (cfr Atti 4,11).
L’atto salvifico secondo l’Apocalisse
Il libro dell’Apocalisse mette in luce in modo particolarmente chiaro il senso dell’atto redentivo di Gesù. Innanzitutto il Verbo di Dio viene presentato come l’Agnello: è ritto in piedi, come immolato, ad indicare che Gesù è morto e risorto. Ha sette corna che indicano la pienezza della potenza ricevuta dal Padre, e sette occhi, che indicano la pienezza della visione penetrante della realtà ottenuta dallo Spirito Santo. È davanti al trono di Dio, il quale tiene nella mano destra un rotolo sigillato con sette sigilli. Questo rotolo rappresenta la Rivelazione (in greco: Apocalisse), il senso della storia dell’umanità. L’Agnello è il solo nell’universo che possa rivelarne il senso e, quando prende il rotolo dalla mano destra di Colui che siede sul trono, prorompe un inno di lode e benedizione nel cielo: “Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra” (Apocalisse 5,9-10). Qual è la motivazione di questa lode? Egli può prendere il libro perché innanzitutto è stato immolato, secondariamente ha riscattato per Dio con il suo sangue uomini di ogni dove, in terzo luogo ha fatto di loro un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Nell’Apocalisse gli uomini sono stati riscattati per diventare regno di sacerdoti: regno come quello di Cristo, che è morto con la corona regale in testa (è re dell’amore), e sacerdozio come quello di Cristo, che ha salvato l’umanità attraverso un atto d’amore intenso e libero.
La consacrazione profetica, sacerdotale e regale
Con la consacrazione battesimale e cresimale anche noi veniamo resi partecipi del ministero profetico, sacerdotale e regale di Gesù. Si tratta di una consacrazione, ovvero un’azione dello Spirito Santo che penetra dentro di noi, ci “intride” di sé e porta una modificazione permanente nella nostra anima (il carattere) che ci abilita ai tre ministeri suddetti. Questa consacrazione ci viene conferita attraverso tre sacramenti: il Battesimo in ordine alla mia salvezza o benessere personale; la Cresima, sacramento della testimonianza, in ordine alla salvezza o benessere degli altri; il sacramento dell’Ordine in ordine alla salvezza degli altri, in quanto membra di un solo corpo che è la Chiesa. Il luogo in cui si vive in modo eminente il ministero profetico, sacerdotale e regale è la Liturgia e in particolare la Celebrazione Eucaristica (cfr SC 2).
L’Eucaristia
L’atto salvifico di Cristo, atto sacerdotale per eccellenza, unico ed eterno sacrificio offerto per la salvezza di tutti gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo si è compiuto nella terra d’Israele circa 2000 anni fa. Rimaneva il problema di come interpellare la libertà di ogni essere umano presente e futuro, in ogni dove, e di come trasmettergli la Grazia attraverso un elemento che insieme lasciasse intatta la libertà dell’uomo e non lasciasse spazio a ragionevoli dubbi (veramente sto partecipando del dono di salvezza di Gesù Cristo?). Si tratta infatti di questioni spirituali, facilmente equivocabili con emozioni o suggestioni.
L’istituzione
Dio ha compiuto una scelta veramente particolare: la sera prima di morire, Gesù celebra la Pasqua ebraica, un rito molto ben definito e codificato, vissuto nell’ambito familiare, ma nel quale si faceva uso di un agnello immolato ritualmente da un sacerdote sull’altare, nello spazio sacro del tempio. Egli stravolge il significato di quel rito sostituendosi, di fatto, all’agnello rituale che era stato immolato mediante la separazione del sangue dal corpo. In questo nuovo rito Gesù presenta del pane, dicendo che è il suo corpo consegnato e del vino, dicendo che è il suo sangue versato per la remissione dei peccati. I Dodici sono chiamati a mangiare di quel pane e a bere di quel vino. Anzi, più precisamente: a mangiare di quel corpo e a bere di quel sangue. Realizza così, improvvisamente, quasi senza nessuna avvisaglia, il discorso incomprensibile tenuto nella sinagoga di Cafarnao dopo la moltiplicazione dei pani: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui” (Giovanni 6,54-56). Gesù suggella le parole dette e i gesti compiuti con un “Fate questo in memoria di me”, vincolando la Chiesa a quel nuovo rito che aveva appena istituito e del quale gli apostoli non comprendevano ancora il significato.
I problemi del nuovo rito
Quel nuovo rito presentava almeno due gravi problemi che lo rendevano diffcile da comprendere. il primo: era un sacrificio in cui mancava la vittima; Gesù aveva ricalcato il rito su un’altra celebrazione nella quale però la vittima era presente; lì, invece, c’era Gesù in carne ed ossa che diceva di mangiare il suo corpo e bere il suo sangue, ma presentava del pane e del vino. Poche ore dopo Gesù viene catturato. Dall’istituzione del rito alla sua morte non passano 24 ore. Questo potrebbe far pensare al fatto che con questa morte il rito trova un suo completamento: abbiamo un corpo e un abbondante versamento di sangue. Qui si inserisce il secondo problema, ancora più grosso del primo: accostare la morte di Gesù all’istituzione dell’Eucaristia che porta con sé veramente tanti problemi. Ne elenco alcuni: 1. l’evento fondativo che solitamente precede l’istituzione di un rito, qui la segue. Il caso mi sembra unico. 2. La vittima sacrificata non è un animale ma un essere umano. 3. la vittima sacrificata non è sacrificata contro la sua volontà: nel contesto del discorso del buon pastore che dà la vita per le sue pecore, Gesù dice: “Io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso”. (Giovanni 10,17b-18a). 4. La vittima sacrificata è il sacerdote stesso che compie l’offerta. 5. L’atto sacerdotale che fa da riferimento è completamente fuori dagli schemi dei riti: fuori da uno spazio sacro, senza un ritualismo celebrativo, senza paramenti, arredi o segni liturgici. E, sia chiaro, è quello il vero atto sacerdotale, che nella Liturgia si attualizza in tempi e i luoghi diversi.
Un rito profetizzato
A ben vedere, però, dobbiamo fare alcune considerazioni: 1. Gesù anticipa in diverse occasioni quello che avrebbe fatto, anche se lo fa con uno stile molto dimesso: Giovanni Battista lo presenta dicendo: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo” (cfr Giovanni 1,29); la modalità con cui manda gli apostoli a cercare la casa in cui avrebbero celebrato il rito pasquale è anch’essa anticipatoria (Marco 14,12-16); anche il discorso del pane di vita è straordinariamente anticipatorio (Giovanni 6,25-66); inoltre, come già detto, Gesù stesso dice che è lui a dare la vita. 2. Se è vero che Gesù istituisce l’Eucaristia all’interno di un rito, tuttavia vuole che l’evento di riferimento di quel rito sia del tutto spogliato della connotazione rituale sacrale. Perché?
L’Amore di Dio, elemento centrale
Gesù forse desidera mettere in luce ciò che è il centro assoluto di quel gesto da Lui compiuto: è l’atto della Rivelazione completa di Dio agli uomini. “Dio è amore” (1Giovanni 4,8) e “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Giovanni 15,13). Ogni volta che celebriamo l’Eucaristia, riviviamo e fortifichiamo l’esperienza di quell’Amore che “è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato” (Romani 5,5). Facciamo esperienza dell’amore più grande, quello divino, e ne facciamo scorta per poter a nostra volta amare non semplicemente con il nostro amore naturale di uomini, ma con quello che ci viene donato attraverso il sacramento dell’Eucaristia. In questo senso l’invocazione dello Spirito Santo riveste un’importanza particolare nella celebrazione Eucaristica. Egli viene infatti invocato solennemente due volte nella preghiera eucaristica: la prima sulle offerte che vengono presentate, affinché “diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri” (preghiera Eucaristica III). La seconda volta viene invocato dopo la consacrazione dicendo: “Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi, che ci nutriamo del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito” (ibidem).
L’Amore “fa” la Chiesa
In ambedue le epìclesi (invocazioni dello Spirito Santo) si fa riferimento al corpo e al sangue. Nella prima è il punto di arrivo: il pane e il vino diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo. Nella seconda epìclesi è il punto di partenza: noi, che riceviamo il corpo e il sangue di Cristo, fa’ che possiamo diventare un solo corpo e un solo spirito. C’è una domanda importante: se con la prima invocazione dello Spirito Santo il pane e il vino, materia semplice e inanimata, diventano il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, il nostro Dio, che cosa succederà mai quando invochiamo lo Spirito Santo per la seconda volta chiedendo che diventiamo un solo corpo e un solo spirito? Forse che lo Spirito Santo non sarà in grado di trasformarci e farci vivere la potentissima esperienza di essere Chiesa? San Paolo ha detto ai Corinzi: “La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio” (1Corinzi 2,4-5). Insiste due volte sulla potenza: dello Spirito e di Dio. Ma la potenza non è quella di fare i miracoli, ma quella che, credendo ai segni di Dio (così sono chiamati per lo più i miracoli nel Vangelo: segni) le persone si convertano diventando altri fuochi d’amore, sorgenti d’amore sparse per il mondo. Perché la vera battaglia è questa. Quante sorgenti d’amore sorgono in risposta al male? Il male non è qualcosa. Semplicemente è rifiutare l’amore e lo si vince diventando tante sorgenti d’amore. L’amore fa la Chiesa e la Chiesa diffonde l’amore nel mondo.
La Comunione: “Il Corpo di Cristo”. “Amen”.
La forza della seconda epìclesi si dispiega in modo particolare al momento della Comunione eucaristica: al fedele che liberamente sceglie di accostarsi alla Comunione eucaristica viene presentata la particola consacrata in modo sommamente succinto: “il Corpo di Cristo“. È Gesù, presente in corpo, sangue, anima e divinità. Tuttavia non è solo presente in modo “statico”, ma è lì per compiere una missione, nel profondo del mio cuore e della mia vita: farmi diventare un solo corpo e un solo spirito, con Lui e con i miei fratelli, di armonizzare ed integrare i doni che Dio mi fa nel multiforme tessuto della comunità cristiana. Quel dono ricco di potenzialità che mi è stato fatto con il Battesimo, accresce la sua attualità nella celebrazione eucaristica.
L’Amore più grande
Ed eccoci giunti all’origine: Dio. È Lui che stiamo cercando, Lui che ci ama, Lui, il cui amore ci ha sorpreso perché ha superato ogni altra esperienza terrena. È Lui che vogliamo amare con cuore libero, senza essere appesantiti, dispersi dietro mille cose, affanni, affezioni. Abbiamo viaggiato insieme fino a qui, con fatica siamo saliti a contemplare la grandezza dell’amore di Dio.
Abbiamo visto svilupparsi, davanti al nostro sguardo, la vita cristiana: essa è innanzitutto una vita di comunità sotto la guida di un pastore, sia nella sua dimensione diocesana, che nella sua dimensione di unità pastorale, con più pastori che agiscono in comunione. La vita di comunità ci rende un solo corpo. Il corpo è quello di Cristo. Il corpo di Cristo ha la missione di salvare. La salvezza viene da un atto d’amore. Questo atto d’amore ha la forma sacerdotale e giunge a tutti gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo attraverso la Liturgia e in special modo la Celebrazione Eucaristica. Gesù l’ha istituita nella sera precedente la sua morte, facendone il rito di quello che sarebbe successo nei giorni a venire (morte, risurrezione, discesa agli inferi, ascensione al cielo). Il sacerdozio di Cristo si esercita in modo particolare nella Celebrazione Eucaristica. Cristo ci partecipa il suo sacerdozio perché anche noi possiamo essere lieti come San Paolo e completare quello che, della passione di Cristo, manca nella nostra carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa.
Dopo aver ammirato il bellissimo paesaggio del disegno di salvezza di Dio, non ci resta che scendere dal monte per dare alle occasioni della vita ordinaria, personale e comunitaria, la forma di questa salvezza. Facciamolo insieme.
L’Eucaristia, centro della comunità
La potenza del cambiamento di una comunità, che è la potenza dell’amore, scaturisce dall’Eucaristia. Quindi la cosa più saggia è migliorare la qualità delle nostre celebrazioni. Detto questo, verrebbe da pensare che dobbiamo prepararle meglio, abbellirle, curarle… certo, ma non basta: il modo di migliorare le nostre celebrazioni è “capire” la salvezza che Dio opera nella celebrazione, dove “capire” non è un atto solo intellettuale. Si tratta di prendere coscienza profondamente di quello che Dio ha fatto per noi, operando la nostra salvezza, e di come ce lo abbia “consegnato” in forma eucaristica.
Due piste, dunque, possiamo seguire. Quella della presa di coscienza: va implorata da Dio, dobbiamo chiedergli il dono di renderci conto di quanto sia grande il suo amore. Capita che partecipiamo in modo troppo abitudinario alla Celebrazione Eucaristica domenicale: dovrebbe toccarci il cuore, lasciarci un’impressione interiore, una voglia di silenzio, di impegno, di pace, di fare sul serio, di poter trattenere la gioia della salvezza nei giorni a seguire. La seconda pista è quella eucaristica, cioè del ringraziamento. Dobbiamo allenarci a lodare e ringraziare Dio. Quale la differenza? La lode è quando si riconosce e si proclama la grandezza di Dio, la sua potenza, la sua bontà, semplicemente perché Dio è Dio. Il ringraziamento è quando si esprime gratitudine e riconoscenza per i doni che ci ha fatto: è una risposta ad un dono. Perché non basta la preghiera di ringraziamento? Perché lodando Dio e ammirandolo il più possibile per quello che è cresce la nostra fede e ci dispone a ringraziare anche per quelle cose nelle quali noi abitualmente non riconosciamo un dono. Il ringraziare per esse con fede apre a Dio le porte per poter compiere meraviglie. Questo, in modo molto succinto, è vivere in modo eucaristico e approfondire sempre più il mistero dell’Eucaristia. Ecco perché la Lettera agli Ebrei ci dice che per mezzo di Gesù “offriamo a Dio continuamente un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome” (Ebrei 13,15). Chi confessa il nome di Dio – il mistero di Dio –, la sua grandezza, la sua bontà, la sua tenerezza, la sua misericordia, il suo amore, il suo perdono, la sua onnipotenza, la sua fantasia, la sua fedeltà, la sua pazienza, la sua magnanimità e tutto quanto lo Spirito Santo ci suggerisce di aggiungerci, offre il sacrificio della lode.
La preghiera di lode non è per nulla facile da portare avanti da soli. Ha bisogno di una comunità che ci educhi e che ci rafforzi in essa. Dobbiamo mettere a fuoco una nozione importante: la gioia va condivisa. Va condivisa! Se non troviamo lo spazio e il tempo per condividere la gioia di Dio con i nostri fratelli e sorelle della comunità, ci spegniamo lentamente. Se non condividiamo la gioia di incontrare Dio, l’incontro con Lui finirà per non essere più una gioia. E non avremo più una gioia da condividere. Forse in non pochi casi è già andata così.
L’insistenza nel proporre forme di preghiera che non si limitano a una recita di formule scritte o allo stare in chiesa è dovuta al fatto che il nostro cristianesimo se vuole sopravvivere dev’essere qualcosa che coinvolge l’uomo dal profondo. Quelli che non amano farsi coinvolgere, neppure sono in grado di coinvolgere altri: e infatti stiamo morendo, ci stiamo riducendo numericamente con una velocità impressionante. nel giro di pochi decenni. La Chiesa che può sopravvivere è una Chiesa attrattiva, ovvero che tocca il cuore dell’uomo, non come sede dei sentimenti, ma dell’amore.
L’Adorazione Eucaristica
L’adorazione eucaristica ci offre la possibilità di porci nel silenzio davanti al Signore Gesù presente nell’Eucaristia e di contemplare il mistero che si compie ogni volta che celebriamo la Messa. Il silenzio che caratterizza l’adorazione favorisce moltissimo la preghiera contemplativa. Non si contano le grazie che le persone ottengono proprio attraverso l’adorazione. Con mia grandissima sorpresa, tra le numerose Giornate mondiali della Gioventù cui ho partecipato, al dire dei giovani l’esperienza che più li ha colpiti è stata l’adorazione eucaristica della veglia con il Papa (in un’esperienza di due settimane, molto variegata: incontri, preghiere, Messe, festa, esperienze caritative, visite culturali, catechesi,…). Attraverso l’adorazione si apre lo scrigno dei tesori della Messa. E quest’ultima, lentamente, plasma e struttura la comunità unificandola in un solo corpo, con tantissimi ruoli differenti. È mio desiderio che in questo anno poniamo le basi per avviare l’adorazione eucaristica perpetua nella nostra Diocesi.
Celebrazione Eucaristica e Liturgia della Parola
Siamo in un tempo in cui a causa della carenza di presbiteri si comincia ad offrire delle Liturgie della Parola al posto delle Messe. Tuttavia oggi sembra che i contorni tra le due liturgie, la Celebrazione Eucaristica (presieduta dal presbitero) e la Liturgia della Parola (presieduta dal diacono o da un altro ministro) sia poco percepita. Addirittura ho sentito, diverse volte e in diversi luoghi, dei diaconi chiamare “Messa” la Liturgia della Parola (e questa è una trasandatezza molto grave) e dei fedeli chiamare comunque Messa la Liturgia che viene celebrata vuoi dal presbitero, vuoi dal ministro laico, segno che non se ne coglie la differenza. Nella parte “ascendente” abbiamo detto che la potenza dell’Eucaristia sta nell’amore di Cristo che nel rito si convoglia e si esprime nelle due epìclesi: sulle offerte perché diventino il corpo e il sangue di Cristo e sulle persone, perché nutrite del corpo e sangue di Cristo diventino un solo corpo e un solo spirito. Queste invocazioni dello Spirito Santo trovano il loro compimento rispettivamente nella consacrazione e nella Comunione che sono i due momenti forti della Messa. Qui possiamo cogliere quanto sia abissale la distanza tra la Celebrazione Eucaristica e la Liturgia della Parola, nonostante la loro somiglianza. Nella Liturgia della Parola con la Comunione in pratica mancano l’offertorio e la preghiera eucaristica: mancano quindi le due epìclesi e la consacrazione. Ed è esattamente lì che abbiamo detto che stanno i doni più grandi dell’Eucaristia, a parte la Comunione eucaristica. In quest’ottica la riforma liturgica ci ha chiesto di rivalutare la partecipazione alla Messa rispetto alla pratica della Comunione fuori della Messa, da usarsi solo quando sovvenga un impedimento. La Sacrosanctum Concilium dice: “Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla Messa, nella quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore con i pani consacrati in questo sacrificio” (SC 55). È una considerazione da tenere presente per le nostre celebrazioni.
In queste circostanze ci rendiamo conto della grazia sacramentale del ministro ordinato che svolge la sua funzione a favore dei fedeli in quanto comunità, Corpo di Cristo che è la Chiesa. E nello stesso tempo comprendiamo quanto grandi siano i doni che vengono conferiti ai fedeli laici nella Liturgia e come, in virtù di essi, siano chiamati ad un ruolo ben più alto di quello cui sono mediamente abituati, in virtù del Sacramento della Cresima, sacramento di testimonianza e di evangelizzazione.
La comunità
La preghiera
È ancora molto diffuso un atteggiamento che già San Paolo denunciava con molta decisione, cioè che per essere “giustificati” sia sufficiente comportarsi bene (le opere della legge). È facile trattare in questo modo anche la preghiera: ridurla a un compito da assolvere, a una serie di cose esteriori da fare, le cosiddette “pratiche di pietà”, oppure anche ridurla a un pensare, riflettere, meditare, sempre riponendo la fiducia in sé stessi, nelle proprie capacità. Mentre la preghiera è un atto interiore dell’anima, che ha la sua origine nello Spirito Santo, e che arriva a coinvolgere la parte più profonda dell’essere umano: il cuore. A ciò dobbiamo orientare il nostro atteggiamento: all’accoglimento della gratuità della presenza e dell’iniziativa del Signore.
Possiamo infatti anche mangiare e bere con Dio, ascoltare la sua parola, possiamo addirittura compiere miracoli (cfr Matteo 7,22-23), o dare la vita (cfr 1Cor 13), ma se non siamo nella Carità, cioè partecipi dell’Amore di Dio, in profonda relazione con Esso, è tutto vano. Notare che “mangiare e bere con lui”, può essere un’allusione eucaristica: sono andato a Messa tutte le domeniche! Ascoltare la sua parola è un’allusione alla relazione con la Parola di Dio. Compiere miracoli è il massimo delle opere che possiamo fare. Ma nessuna di queste cose ci giustifica (nel senso di renderci giusti, cioè santi). Arriviamo così al paradosso che certe modalità di preghiera non realizzano pienamente l’incontro con Dio e non favoriscono la mia assimilazione a Lui.
Tra le preghiere che la nostra tradizione ci consegna, vorrei qui raccomandare quella del Santo Rosario. Mi è caro riportare l’Angelus del 29 ottobre 1978, il primo dopo l’inizio del ministero petrino di
San Giovanni Paolo II. Egli lo ha voluto dedicare alla Vergine Maria, alla quale si era consacrato anni prima, assumendo poi come motto il “Totus tuus”. In particolare ha voluto parlare del Rosario:
«Il Rosario è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella sua profondità. In questa preghiera ripetiamo molte volte le parole che la Vergine Maria udì dall’Arcangelo e dalla sua parente Elisabetta. A queste parole si associa tutta la Chiesa. Si può dire che il Rosario è, in certo modo, un commento- preghiera dell’ultimo capitolo della Costituzione Lumen Gentium del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa. Difatti, sullo sfondo delle parole “Ave, Maria”, passano davanti agli occhi dell’anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono nell’insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci mettono in comunione viva con Gesù attraverso – potremmo dire – il Cuore della sua Madre. Nello stesso tempo il nostro cuore può racchiudere in queste decine del Rosario tutti i fatti che compongono la vita dell’individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e dell’umanità. Vicende personali e quelle del prossimo, e in modo particolare di coloro che ci sono più vicini, che ci stanno più a cuore. Così la semplice preghiera del Rosario batte il ritmo della vita umana».
Dopo tanti anni, capisco il perché dell’insistenza, da parte della Madonna in occasione delle apparizioni, sulla recita del Santo Rosario. La semplicità di questa preghiera aiuta i fedeli a lasciarsi riempire dall’amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato (cfr Romani 5,5).
Le unità pastorali
Il nostro cammino verso le unità pastorali continua: siamo ancora in cammino “verso” perché il lavoro da fare è tanto, soprattutto nelle modalità di interazione e di creazione di una vita comunitaria. Qui il passo è veramente grande e ingannevole. Grande: perché si tratta in qualche modo di ricominciare. Includere tante altre persone in dinamiche relazionali è quasi come ripartire daccapo. Ingannevole: perché la nostra mente ci dice di ripetere il già conosciuto, ma la forma di comunità che ci ha portato qui è anche il “già fallito”. È una legge psicologica: tendiamo a ripetere le esperienze negative della nostra infanzia perché sono il “già conosciuto”. Alla base del rinnovamento della Chiesa sta un riconoscimento del reale come luogo teologico, come manifestazione di Dio. La bella notizia è che la brutta notizia che abbiamo fallito è la vera risorsa per un autentico cambiamento.
Il sinodo
Il cammino di rinnovamento della chiesa iniziato secondo la dimensione della sinodalità avviato da Papa Francesco non finisce certo con la sua morte. La sinodalità è una modalità di comunione cui la Chiesa non può rinunciare senza smettere essere pienamente Chiesa. Il nostro sinodo diocesano continua: il passaggio alle unità pastorali è ben lungi dall’essere concluso e richiede molto dialogo: non si tratta di giungere ad una nuova organizzazione tra più parrocchie, ma si tratta di ricercare assieme un modo di fare comunità camminando assieme, sostenendosi a vicenda, incoraggiandosi e perdonandosi sempre e di nuovo.
La Pastorale giovanile
Essendo la Pastorale giovanile una priorità assoluta all’interno delle nostre comunità, perché è quella che trasmette la fede alle generazioni presenti e future, dobbiamo avere almeno a livello di unità pastorale un percorso sviluppato e funzionante per prenderci cura dei giovani: una società che non si sa prendere cura dei suoi piccoli è una società morente. Invito i sacerdoti a collaborare con l’Ufficio per la Pastorale giovanile al fine di rendere ogni unità pastorale operativa da questo punto di vista. Chiedo fin d’ora che ogni unità pastorale mandi dei giovani alla Giornata Mondiale della Gioventù in Corea nel 2027.
Le vocazioni
Tra le varie forme del prendersi cura dei giovani c’è quella delle vocazioni ai diversi stati di vita: sacerdozio, vita consacrata, matrimonio. La vita consacrata in particolare ha subito una flessione molto più forte degli altri stati di vita. Per essa dobbiamo pregare. Propongo che l’anno 2025-2026 sia un anno vocazionale, in cui preghiamo particolarmente per le vocazioni: chiediamo al Signore il dono di santi sacerdoti, santi consacrati e sante famiglie.
I ministeri
Mi sono reso conto che il tema della formazione dei laici è molto problematico perché uscire dalle paludi di una formazione intellettualistica è veramente faticoso. Veniamo da un’idea di Chiesa in cui la formazione è quasi esclusivamente intellettuale. Avviare percorsi di prassi cristiana o ministeriale, di mistagogia, al di fuori di un contesto di tradizione sinodale chiede uno sforzo che dobbiamo fare con generosità e che non è immediato.
La lettera pastorale al servizio della comunione
La lettera pastorale serve perché la Chiesa locale possa ascoltare le indicazioni del suo pastore, il vescovo, che ha una grazia di stato e un sacramento in ordine a questo: il grado dell’episcopato è la pienezza del sacramento dell’Ordine. Fatte le debite proporzioni, forse può essere interessante fare una sorta di lettera pastorale anche nell’unità pastorale. Magari con l’intento evangelizzatore di distribuirla a tutte le persone, anche quelle che non si vedono in chiesa, e mandare un messaggio, creare un rapporto. Comunque le indicazioni della lettera pastorale, come dicevamo, non sono cose da eseguire, ma per lo più sono cose sulle quali pregare e in seguito condividere. La lettera viene presentata a settembre per dare tempo alle comunità di pregarci, confrontarsi e creare dei percorsi condivisi che si ritengono utili o arricchenti o formativi.
L’anno pastorale legato all’anno liturgico
L’anno pastorale inizia con l’Avvento: perché? Perché la vita della Chiesa, avendo la sua origine in Dio e la sua forza nello Spirito Santo, dipende molto non dall’organizzazione (che pure non guasta: semplifica tanti problemi), ma dall’effusione della Grazia di Dio sulla comunità e la grazia che viene dal vivere l’anno liturgico è la prima e la più forte. Per questo, agganciare la vita delle comunità all’anno liturgico è una scelta strategica che premia. Certamente si richiede di affrontare anche i problemi concreti di agganciare le persone dopo l’estate, prima che siano ripiene di impegni, ma si possono trovare con fantasia soluzioni, a seconda delle attività, che permettano di non perdere le persone e neppure l’aggancio con l’anno liturgico.
La verifica
Un confronto vero di comunità sulla lettera pastorale non può dirsi completo se non include, alla fine del percorso, un tempo di verifica. Cerchiamo di far diventare nostra questa modalità che non va mai data per scontata.
Appendice 1: il pastore nella Bibbia
Riportiamo tutti i brani della Bibbia in cui si parla dei pastori intendendo coloro che hanno il compito di pascere il popolo. Può essere utile per meditarli.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla (Salmi 23,1).
Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità, sii loro pastore e sostegno per sempre (Salmi 28,9).
Lo allontanò dalle pecore madri per farne il pastore di Giacobbe, suo popolo, Israele, sua eredità.
Per loro, un pastore dal cuore integro e li guidò con mano intelligente (Salmi 78,71-72).
Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. Seduto sui cherubini, risplendi (Salmi 80,2).
Le parole dei saggi sono come pungoli, e come chiodi piantati sono i detti delle collezioni: sono dati da un solo pastore (Qohelet 12,11).
Non misericordia dell’uomo riguarda al suo prossimo, la misericordia del Signore ogni essere vivente. Egli rimprovera, corregge, ammaestra e guida come un pastore il suo gregge (Siracide 18,13).
Come un pastore e gli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri (Isaia 40,11).
Io dico a Ciro: “Mio pastore”; ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme: “Sarai riedificata”, e al tempio: “Sarai riedificato dalle fondamenta” (Isaia 44,28).
Allora si ricordarono dei giorni antichi, di Mosè suo servo. Dov’è colui che lo fece salire dal mare con il pastore del suo gregge? Dov’è colui che gli pose nell’intimo il suo santo spirito, colui che fece camminare alla destra di Mosè il suo braccio glorioso, che divise le acque davanti a loro acquistandosi un nome eterno, colui che li fece avanzare tra i flutti come un cavallo nella steppa? (Isaia 63,11-13).
Ascoltate, genti, la parola del Signore, annunciatela alle isole più lontane e dite: “Chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge” (Geremia 31,10).
Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate
(Ezechiele 34,5).
Susciterò per loro un pastore che le pascerà, il mio servo Davide. Egli le condurrà al pascolo, sarà il loro pastore (Ezechiele 34,23).
Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti; seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica (Ezechiele 37,24).
Perciò io dissi: “Non sarò più il vostro pastore. Chi vuole morire muoia, chi vuole perire perisca, quelle che rimangono si divorino pure fra loro!”
Poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non avrà cura di quelle che si perdono, non cercherà le giovani, non curerà le malate, non nutrirà quelle ancora sane; mangerà invece le carni delle più grasse e strapperà loro persino le unghie. Guai al pastore stolto che abbandona il gregge! Una spada colpisca il suo braccio e il suo occhio destro. Tutto il suo braccio si inaridisca e tutto il suo occhio destro resti accecato (Zaccaria 11,16-17).
Insorgi, spada, contro il mio pastore, contro colui che è mio compagno. Oracolo del Signore degli eserciti. Percuote il pastore e sia disperso il gregge, allora volgerò la mano anche contro i suoi piccoli (Zaccaria 13,7).
E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele (Matteo 2,6).
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre (Matteo 25,32).
Allora Gesù disse loro: “Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge“ chiuse (Matteo 26,31; cfr Marco 14,27).
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore (Giovanni 10,11).
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: anche io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore (Giovanni 10,14-16).
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore» (Giovanni 21,15-17).
Il Dio della pace, che ha ricondotto dai morti il Pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un’alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen (Ebrei 13,20-21).
Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime (1Pietro 2,25).
E quando apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce (1Pietro 5,4).
Perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi (Apocalisse 7,17).
Appendice 2: testi per la Lectio divina
Riportiamo il testo di due capitoli (12 e 13) della prima Lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi per la Lectio divina personale e comunitaria.
1Riguardo ai doni dello Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell’ignoranza. 2Voi sapete infatti che, quando eravate pagani, vi lasciavate trascinare senza alcun controllo verso gli idoli muti. 3Perciò io vi dichiaro: nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire: “Gesù è anàtema!”; e nessuno può dire: “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo.
4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 7A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 9a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro l’interpretazione delle lingue. 11Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole.
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito.
14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. 15Se il piede dicesse: “Poiché non sono mano, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. 16E se l’orecchio dicesse: “Poiché non sono occhio, non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe parte del corpo. 17Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe
l’odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. 21Non può l’occhio dire alla mano: “Non ho bisogno di te”; oppure la testa ai piedi: “Non ho bisogno di voi”. 22Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie; 23e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, 24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui.
27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue membra. 28Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. 29Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? 30Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? 31Desiderate invece intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più sublime.
1Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
2E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
4La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgoglio, 5non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 6non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 7Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
8La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. 9Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 10Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. 11Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
12Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. 13Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!
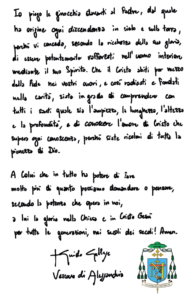

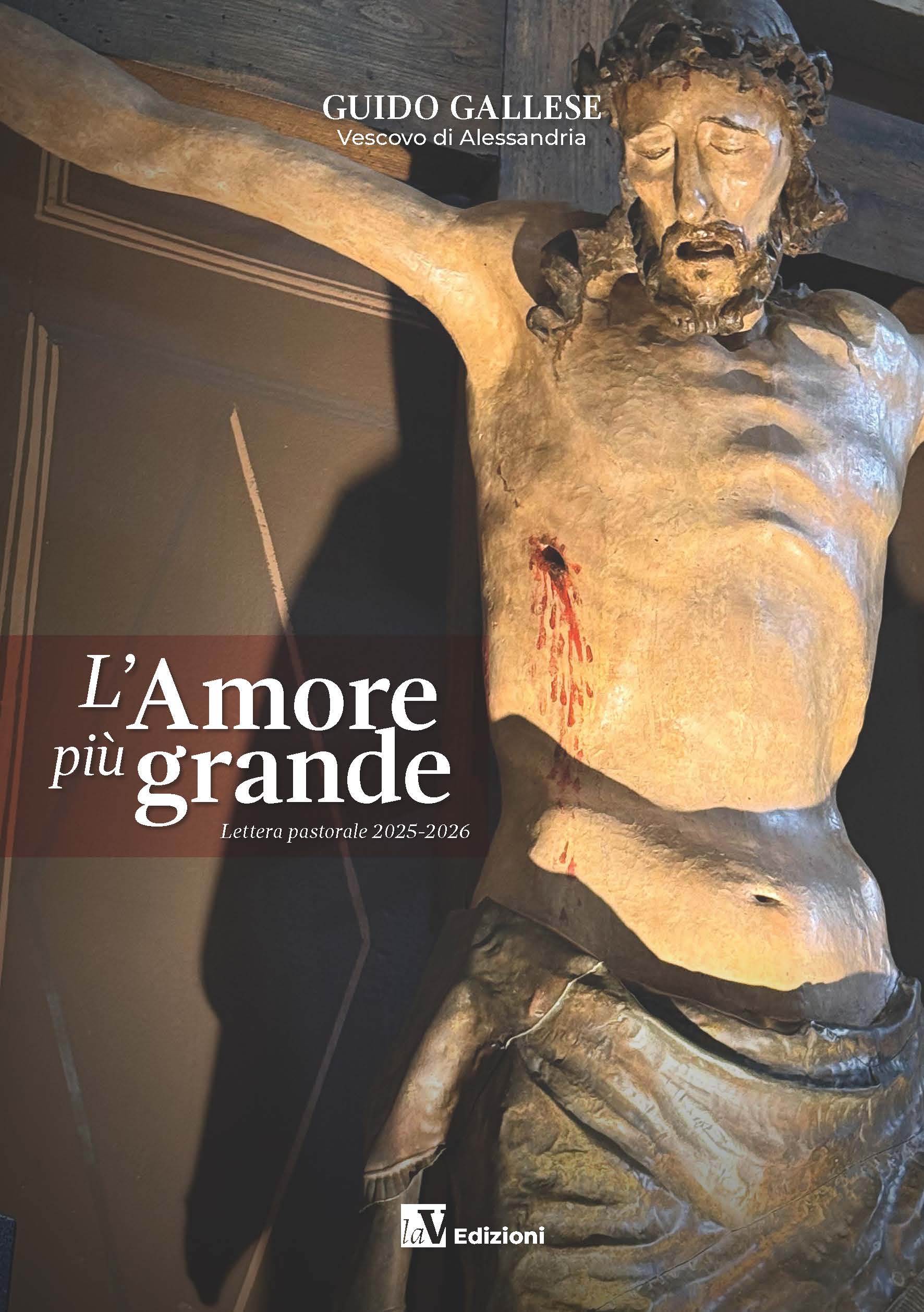
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.